(Siena)
| Pubblicato su: | Il Regno, anno I, fasc. 14, pp. 6-8 | ||
| (6-7-8) |
|||
| Data: | 28 febbraio 1904 |

pag.6

pag.7
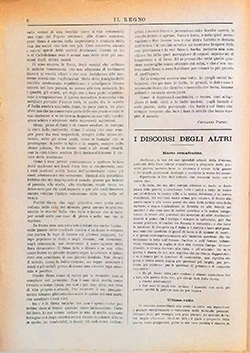
pag.8
6
Ci sono a Siena scuole d'ogni razza e d'ogni grado: dalle scolette delle contrade ove i bimbi dell'Oca o della Tartuca vanno a iniziarsi ai misteri dell'alfabeto, fino allo studio che ebbe ed ha maestri famosi e fabbrica ogni anno un numero rispettabile di nuovi dottori. Ma non è in codesti santuari della piccola e della grande dottrina dove i «pionieri della civiltà» o i «ministri della scienza» spendono il loro fiato nell'ore ordinate dal regolamento, che si posson trovare, nella bella città toscana, gli insegnamenti che ci son necessari.
Siena, rimasta quasi incorrotta dentro la cerchia delle sue rosse mura, ove lavorò l'ingegno michelangiolesco di Baldassarre Peruzzi, conserva nella sua purità medievale il più alto insegnamento che un centro di civiltà possa donare a coloro che l'intendono. Siena è tutta una gigantesca lezione, fatta di pietre e di mattoni, ornata di sculture e di freschi, impressa sulle linee dei palazzi e al sommo delle torri, distesa sui colli come una stella rosseggiante in mezzo al verde. Lezione che non si chiude nelle mura di un vecchio edificio, ma si mostra aperta, chiara, nitida alla carezza solare e al tremito delle stelle, — che non si restringe a certe ore o a certi momenti, ma in ogni ora, in ogni momento, da anni e da secoli sta nell'aspettazione degli occhi che la discoprano e degli orecchi che l'ascoltino.
E così, senza essermi assiso dinanzi alla cattedra di nessun distributore di conoscenza, Siena mi ha parlato con secreta eloquenza, ed io non dimenticherò mai l'esortazioni di grandezza, di nobiltà e d'orgoglio che mi hanno detto le sue torri mozzate e le sue sibille melanconiche.
Gravi parole mi ha detto la terra dei Petrucci e dei Piccolomini, gravi e dimenticate parole che nessuno vuol più udire o nessuno vuol più ripetere — parole di fierezza e di solitudine, miste al vento delle sue colline e al rombo delle sue campane.
Edificata su tre colli, come la madre Roma, da, cui discese nei tempi dì Augusto, essa sembra spiare dalle sue alture i malsicuri borghi e i lontani varchi. Intorno la cinge la corona delle belle mura, che mal la difesero contro l'oste spagnolesca di Cosimo, ma che ricordano le agguerrite vigilie del Comune e le tolgono, almeno per ora, l'onta dei sobborghi. E dentro le mura e sovra i colli si elevano diritte nel cielo le torri dei
7
palazzi e i campanili delle chiese, torri mozzate e arcate non compiute, tutte spasimanti verso l'alto, in un desiderio comune di elevazione.
Così chiusa sui monti, irta di altezze, aspirando ad innalzare sulle alture, essa c'insegna come gli uomini che la costrussero seppero i tre segreti della nobile potenza: la solitudine, la difesa e l'orgoglio.
Infatti la torre è il simbolo architettonico della superbia — già nella tradizione ebraica, Nembrod irato contro Jehovah vuol innalzare la torre babelica che giunga ai domini del Dio nemico. E a Siena ogni famiglia ebbe la sua torre e vie più che la fortuna del parentado cresceva, la torre s'alzava e Siena era piena di queste torri che s'inalzavano e crescevano e si spingevano verso il bel cielo. E dall'alto della torre il signore guardava i nemici, e lanciava balestre, e spingeva i suoi sguardi sulla campagna a vedere se qualche gonfalone spuntasse dietro ai monti, a insidiare la signoria e il popolo di Siena. Le torri erano le vedette e le difese, erano i segni della potenza e le guardie munite. E la superbia aumentava colle loro pietre. Come alberi minerali il loro tronco si accresceva ogni primavera. Una volta, una famiglia, sulla piazza del Campo, giunse ad elevare la sua più in alto di quella del Comune. L'individuo voleva soverchiare la comunità. Ma la Signoria non permise un tale affronto e la torre fu mozzata.
E così o per volere dei Signori, o per odio di nemici le torri furono a poco a poco abbassate, decapitate, atterrate. L'ira spagnola, la prudenza fiorentina non risparmiarono quelle che la Repubblica aveva lasciato liberamente protendere in alto i loro merli. E, dopo, il gusto della decadenza distrusse le ultime, e fin oggi la moderna insipienza un'altra ne ha sagrificata, un'antichissima torre di origine romana, la Torre del Pulcino.
Ma basta l'unica intatta, la Torre del Mangia, per farci comprendere l'istinto di solitaria sovranità che mosse i dominatori di Siena a far grandeggiare nell'aria quei testimoni della loro forza vigilante.
Io son voluto salire su quella torre, e attraverso gli oscuri scalini marmorei, e per le scalette aeree io son giunto al sommo, ove la grande campana segna le ore della quiete dopo avere squillato per le vittorie. E lassù, tramezzo agli ultimi merli, io ho contemplato Siena distesa ai miei piedi, intorno alla leggiadra conchiglia della piazza del Campo, e ho visto i piccoli senesi aggirarsi inquieti attorno alla bianca Fonte Gaia. Il sole splendeva sul mondo, grande era il silenzio e la cerchia delle rosse mura e la cerchia degli azzurri monti chiudevano sole il mio sguardo. Lassù, colla faccia percossa dal vento, nella quiete sovrumana, io ho sentito quello che il signore di un castello o il tiranno di una città doveva sentire, solo e in alto, cogli occhi grifagni fissi sopra il suo dominio. E ho compreso la gioia del solitario che sa che ovunque arriva il suo sguardo la sua parola suona ordine, e lungi al soffio petulante del volgo assapora la gioia della suprema libertà.
«Alti e soli, ha ripetuto la torre, alti e soli in mezzo ai venti e alle rondini, alti e soli sopra le basse dimore, alti e soli sopra le mormoranti moltitudini. Di quassù ogni cosa ti par bella e desiderabile, i monti lontani ti nascondono le loro rupi, gli uomini lontani non ti fanno scorgere i loro volti di bestie avide, le case lontane non ti fanno udire i gridi di rabbia e di affanno dei loro abitatori. La torre ti libera senza seppellirti. Tu godi le belle cose del mondo senza vederne le brutture e sospeso sopra la terra senti che in te solo dorme il tuo destino. Educatrice di nobiltà e di energia io sono, perchè creata da nobili forti. Nei miei mattoni ben stretti fra loro, nelle mie pietre ben cementate, infusero i miei signori una sconosciuta virtù che può inebriare. Perciò bada bene, o pellegrino, ch'io sono alta e dò le vertigini, come tutte le grandi cose, come il potere e la gloria mie sorelle».
E mentre la torre diceva a me stesso, colla mia bocca, queste parole, uscì fuori dalla stretta scala un giovinetto francescano, dal bel volto un po' pallido, chiuso nel saio trecentesco e calzato coi sandali silenziosi.
Egli aveva in mano un antico canocchiale, ricoperto di bianca pelle, forse una lontana eredità di qualche priore amante delle stelle, e appoggiato ai merli robusti egli si pose a guardare qua e là sul vasto orizzonte, quasi cercasse una cosa perduta per sempre. Ed io immaginai che quel fraticello venisse lì ogni giorno, col suo canocchiale indebolito dal tempo, a rivedere la sua casa lontana, perduta su qualche colle.
Mi parve in quell'istante che fosse il simbolo della città che ricercasse il suo nido antico, o il simbolo della fede che andasse in traccia dei romitaggi ove si macerarono i santi. La potenza della città è sparita e sparita è la purezza della fede: quel giovinetto ammantato, dal viso dolce, quasi uscito da una tavola dell'Angelico, pareva che s'attristasse della doppia scomparsa. Ed io scesi dalla torre, tornai sulla piazza, come se in quel momento i grandi flutti della storia, che innalzano e abbassano, fossero passati rapidi e terribili innanzi a me.
Scesi nella città e m'aggirai per le vie tortuose, tra le case rossastre, ove le bifore marmoree chiudono sconosciuti tesori; per le vie salienti verso le chiese deserte e per quelle che discendono verso le case delle sante e verso le fonti sotterranee.
Le vie son tortuose, pensavo, per dare l'idea dell'infinito e del diverso. Le nostre vie diritte hanno un fine certo, noi sappiamo ch'esse si taglieranno ad angolo retto nel punto designato dagli edili, e che formeranno quadrati e rettangoli perfetti, come vuole la nostra estetica, da agrimensori. Invece in queste strade noi possiamo aspettare ogni momento una nuova meraviglia: a ogni voltata scopri un palazzo che sale su per una costa, o una stradicciuola che scende al basso coperta d'archi e di volte, o ti s'apre una piazza luminosa ove l'erba cresce e i fanciulli s'indugiano. Niente richiama la nostra vita moderna, meccanica, regolare, ufficiale, burocratica, uniforme.
Tutto qui è capriccio e irregolarità. In queste vie fatte per gli amori e per gli agguati tu non vedi la folla rumorosa, fatta di operai brutali o di borghesi impettiti e idioti, che ti spinge e ti attornia nelle grandi città moderne, ma incontri solo qualche lenta coppia di buoi dalle lunghe corna, che trascinano delle travi annerite o dei frutti della terra — delle fanciulle dai grandi cappelli coperti di semplici fiori, degli artieri silenziosi e pensosi che tornano dall'avere accarezzato il legno o domato il ferro.
Il silenzio di questa città è un pegno di raccoglimento. Bisogna, fra queste mura, che coloro che non voglion morire, pensino al passato. Ed è Siena infatti una città del passato. Malgrado che la luce elettrica inetta la chiarità dei suoi globi per le sue strade e che
8
sulle rovine di una vecchia torre si stia costruendo una Casa del Popolo destinata alle future concioni, pure Siena è ancora tutta impregnata e aromata della vita dei secoli che non son più. Essa conserva ancora i vecchi spiriti delle società dominanti. Fedele al Re e al Cattolicismo essa è ormai una delle città più immuni dagli ultimi morbi.
Ci sono ancora, in Siena, degli uomini che serbano le antiche venerazioni, che non sdegnano di inchinarsi dinanzi ai vecchi altari e che non indulgono alle moderne scamiciate vociferazioni. Molte delle famiglie della vecchia aristocrazia repubblicana e principesca vivono ancora nei loro palazzi, in mezzo alle loro memorie, fra ì quadri, gli arazzi, gli stipi che i loro padri acquistarono o conquistarono. E questa atmosfera di raccolta vita nobiliare pervade l'intera città, la quale, fra le sorelle d'Italia sembra una bella dama, un poco antica, un poco triste, ma che ha conservato parte delle sue grazie e tutte le sue ricchezze e se ne vive in disparte, in una villa turrita, quasi schiva e sdegnosa delle universali agitazioni.
Siena, piena di fonti e di casate secolari, ci insegna la virtù della continuità. Come l'acqua che esce sempre pura dai suoi acquedotti, sempre colla stessa armonia, sotto gli stessi archi; come le famiglie che si prolungano di padre in figlio o in nepote, sempre nello stesso palazzo, fra le stesse armi e gli stessi ricordi, così la città intera sembra dirci instancabilmente il valore della tradizione.
Come i suoi pittori continuarono a mettere le loro dolci madonne nei fondi d'oro fino al cinquecento, così i suoi moderni nobili fanno dell'archeologia come gli abati aristocratici del settecento. Dinanzi alla mutabilità febbrile che sta disgregando il mondo, questa pia fedeltà al passato, alla storia, alla tradizione, rende Siena un dolce covo per chi vuol sognare e per chi vuol ritrovare ancora vergine l'antica concezione delle vita bella ed eroica.
Perché Siena, che oggi potrebbe esser posta nella collana delle città del silenzio, porta ancora in ogni suo angolo le traccie della vita forte e feroce che si agitò per secoli nelle sue case di pietra e nelle sue vie di mattoni.
Da Roma essa non tolse solo i coloni ma anche l'arma: sulle piazze delle contrade ancora s'inalzano le colonne che portan le lupe di bronzo coi gloriosi poppanti. Le lupe popolano la città, e negli stemmi, sui cornicioni negli ornamenti, noi ritroviamo il muso aguzzo della fiera divoratrice. E Siena urlò e divorò e se non ebbe come Roma un grande impero seppe acquistare e difendere con grandezza il suo piccolo dominio. Non divorò il mondo, come la belva romana, ma seppe mostrare i denti e gli artigli prima di essere una vecchia lupa sdentata e pacifica.
Poiché Siena come ci esalta per le memorie così ci assopisce nel presente. Non è una città morta, come Orvieto o come Assisi, ma non è più una città che viva di vita propria e attuale. Per ricevere il suo insegnamento bisogna piuttosto rievocare le anime dei suoi morti, che ascoltare i suoi vivi.
Ma c'è in Siena un'arte che non è spenta e che potrebbe dare ai Senesi qualche virile incitamento: l'arte del ferro. Io son voluto andare in una di quelle nascoste botteghe ove degli artefici oscuri stanno foggiando il ferro in spade, in candelabri, in fanali. Gli steli ferrei s'allungano, i mostri ferrei si protendono colle bocche aperte, le corone ferree si aprono. Tutto è ferro, e tutto quel meraviglioso e fine lavoro non è che ferro battuto e domato dall'uomo. Un vecchio artefice mi mostrava le opere della sua giovinezza e la sua bianca barba metteva una nota chiara fra tutto quel nereggiare di copiosi capolavori di leggerezza e di forza. Ed io pensai che tutte quelle graziose meraviglie erano ottenute coi colpi, e che c'era voluto assai fuoco e assai battiture per creare la più piccola di quell'opere.
Ed io compresi ancora una volta, in quegli oscuri laboratori, che per fare le belle, le grandi, le dolci cose é necessario fuoco che dissolva e martello che batta, fiamme ardenti e costanza senza pietà.
Come si foggiano i candelabri, o Senesi, così si foggiano le belle città e le belle nazioni: cogli incendi e colle guerre, colla pervicacia che batte e col fuoco che strugge vengono alla luce i fiori di civiltà, che fanno stupire il mondo.
◄ Indice 1904
◄ Il Regno
◄ Cronologia